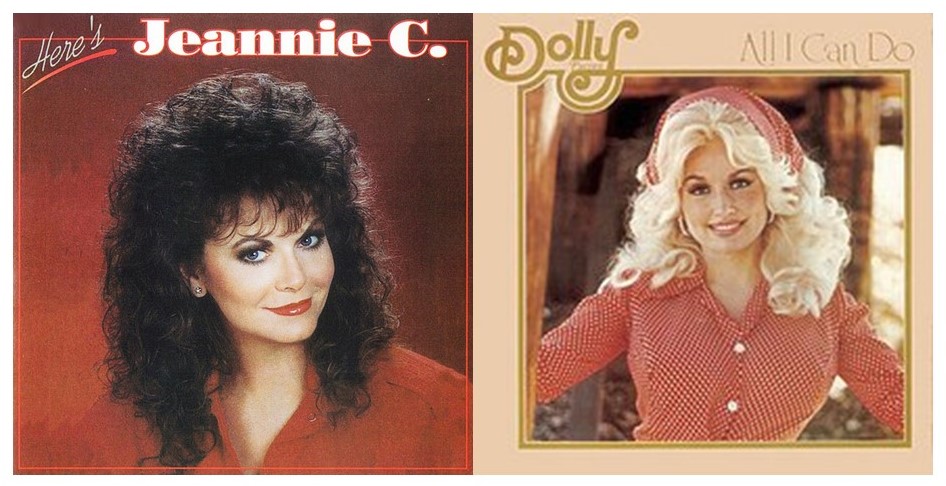Ben dodici dischi all’attivo, riconoscimenti da entrambi i lati dell’Oceano, una personalità che è andata maturando attraverso fasi della vita che purtroppo le hanno riservato vicende anche tragiche e un successo che forse è pronto ad arrivare grazie a questo disco che più di altri rappresenta un’artista di grande talento: Hilary Scott. A ventanni dalla scomparsa del fratello Scott (dal quale, in segno di profondo affetto, ha preso il suo nome d’arte), Hilary ha confezionato, producendo lei stessa session ispirate e vibranti in compagnia della sua ‘tour band’, un album che la pone a fianco delle grandi voci femminili della canzone americana, da Carole King a Karla Bonoff, in un susseguirsi di inflessioni ed influenze che vanno dalla country music al pop e al soul. “Don’t Call Me Angel” contiene nove originali ed una cover (una brillante ed intelligente “Kiss” di Prince che comunque è molto distante dallo spirito del cantante di Minneapolis) interpretate con cuore ed anima da una voce le cui sfumature sono molteplici e sempre coinvolgenti. Ritmi che vanno dalle ballate ai ‘midtempo’ e che si colorano di tonalità pastello grazie alle chitarre preziose di Johnny Lee Schell, dell’organo Hammond del veterano di mille session Mike Finnigan (ha suonato, tra gli altri, con Bonnie Raitt, Taj Mahal, Etta James, Jimi Hendrix e Leonard Cohen) e del piano della protagonista che in questo disco acquista maggiore spazio rispetto ai precedenti, a sottolineare la voglia di essere più ‘trasversale’ nei generi. Bastano pochi ascolti per entrare nel mondo di Hilary Scott ed innamorarsene, se si è sensibili alle canzoni che hanno melodie intrise di sofferenza, speranza e passione, forse non facilmente etichettabili ma spesso commoventi e profonde. “Don’t Call Me Angel” è un lavoro importante e speciale, per i ricordi familiari e per una saggezza ottenuta e messa al servizio di un songwriting di qualità e le dieci canzoni che lo compongono scorrono con naturalezza e chiedono solo di essere riascoltate e penetrate nel loro intrinseco significato. La title-track che inaugura l’album, l’intima e accorata “Not Used To Being Used To”, la freschezza ed il ritmo di “You Will Be Mine”, gli intrecci di piano e organo di “Make It Right” che la rendono ballata sontuosa, così come “Heartless” che ricorda le grandi ‘balladeer’ californiane degli anni settanta (Valerie Carter su tutte) sono tra i momenti migliori. “Unlove Story” vede Hilary Scott esibirsi all’ukulele ed immancabilmente spuntano sottili colorazioni ‘caraibiche’, “Moon And Back” è un altro esempio di equilibrio e gusto in una ballata gustosamente pianistica, “In Time” e “Here I Am” chiudono il cerchio e mostrano ancora grande umanità e capacità. Sperando che non rimanga una ‘best kept secret’. (Remo Ricaldone)